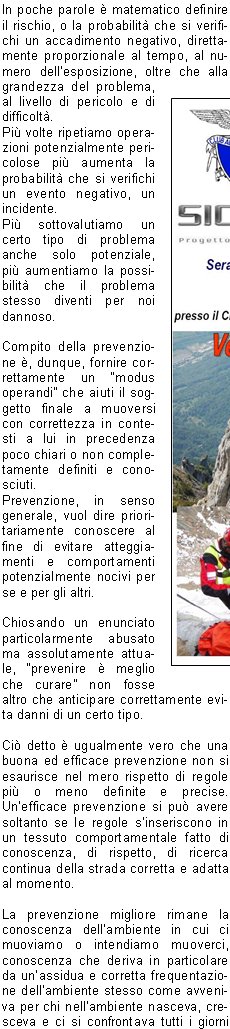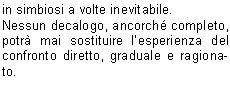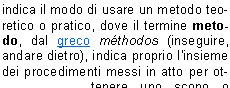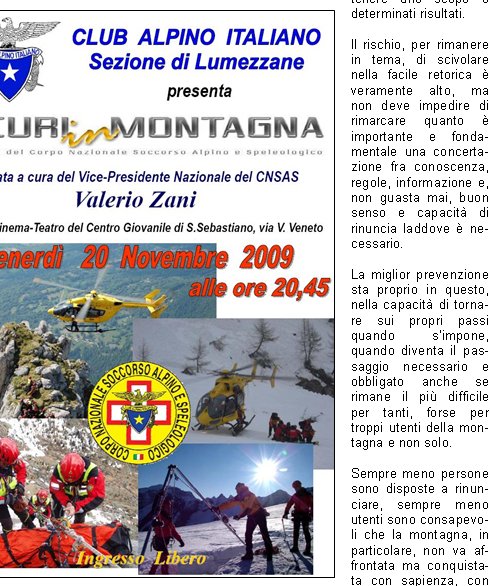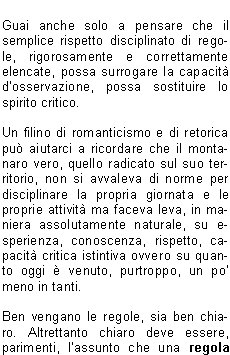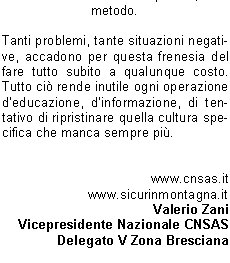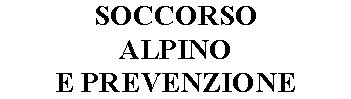
Quando si parla di Soccorso Alpino si è portati a pensare, quasi in maniera automatica, ad incidenti, dispersi, valanghe o disgrazie più o meno grandi.
Poco conosciuta, ai più, è, infatti, l’attività di prevenzione e informazione che il CNSAS svolge regolarmente e in maniera capillare sull’intero territorio nazionale.
Non a caso l’Articolo 2 dello Statuto del CNSAS recita:
“Le finalità del C.N.S.A.S. sono:
· contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche.
· soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti, anche in collaborazione con Organizzazioni esterne.
concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali”.
E’ significativo rilevare che, nelle finalità di un’Istituzione storicamente legata alla montagna, alla speleologia e all’ambiente impervio in genere, la finalità prima è proprio quella di contribuire alla vigilanza e alla prevenzione al fine di limitare e ridurre quanto possibile incidenti e infortuni.
Spesso la montagna, nel senso più ampio e completo del termine, è oggetto di campagne mediatiche enfatiche attente anche al minimo problema, capaci di amplificare oltre modo situazioni o avvenimenti che sovente risultano trasformarti erroneamente in tragedie figlie della sete di sangue che “la montagna assassina” deve sistematicamente placare.
La velocità e la capacità di trasmissione delle notizie, notevolmente incrementate negli ultimi anni, unite ad
un’informazione non sempre precisa e supportata da dati certi, provocano nell’opinione pubblica e nel cittadino non particolarmente avvezzo a quest’ambiente reazioni spesso errate e conclusioni fuori luogo che contribuiscono a generare luoghi comuni e preconcetti assolutamente falsi, deleteri per la montagna e i suoi frequentatori.
Parallelo e antitetico, se vogliamo, ultimamente è anche tutto un fiorire d’iniziative e progetti volti alla sicurezza nel senso più ampio e forse abusato del termine stesso.
Da tempo, infatti, si assiste ad un incremento notevole di proposte aventi come tema la montagna e come obiettivo l’incolumità dei suoi “clienti”.
Progetti, iniziative, Fondazioni specifiche, siti Internet, stampa finalizzata, conferenze, convegni, di tutto di più con lo scopo di porre l’accento su un tema improvvisamente tanto caro dove una pluralità assoluta di soggetti si prodiga in consigli, suggerimenti, proposte e quant’altro ritenuto dagli stessi utile alla causa.
Ogni iniziativa, sia ben inteso, è lodevole e apprezzabile non fosse altro che per gli importanti obiettivi definiti e per gli impegni profusi nello sforzo di raggiungerli.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, pertanto, è in prima linea, a fianco di tanti altri, nel tentativo di contribuire fattivamente al raggiungimento di risultati concreti e, soprattutto, oggettivabili e spendibili per la tanto vituperata sicurezza.
La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati", ovvero sapere che quello che faremo non provocherà danni.
Il presupposto della conoscenza è
fondamentale da un punto di vista epistemologico, poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per quest’esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza precisa, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione di norme e di comportamenti adeguati e specifici di sicurezza rende più difficile il verificarsi d’eventi dannosi e d’incidenti.
Nella lingua italiana, come in altre lingue, il termine sicurezza non viene molto bene differenziato da quello di prevenzione. Forse, più che un problema linguistico, si tratta di un residuo d’antichi concetti sul fato, sull'ineluttabile e sulla prevalenza del destino e della fortuna rispetto all'intelligenza umana.
Quando accade un incidente, ancora oggi, si sente parlare di sfortuna. Si può affermare che, spesso, un incidente, nel senso più ampio del termine, è causato dal mancato rispetto di norme, da atteggiamenti sbagliati, da comportamenti gravi e impropri.
La montagna, come ogni altro ambiente indistintamente, necessita di principi basilari sacrosanti affinché la fruizione possa avvenire in maniera propria pur nella consapevolezza che il “rischio zero” è pressoché impossibile da raggiungere.
Posto che i pericoli sono suddivisi in oggettivi (legati all'ambiente) e soggettivi (legati alle persone), la condizione indispensabile è quella di ridurre il risultato della formula matematica che lega il rischio a due fattori significativi ovvero la frequenza o probabilità d’accadimento e la magnitudo delle conseguenze.